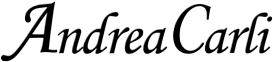Paesaggio, natura morta, figura umana, ritratto: quest’ultimo a mio parere, è dove Carli raggiunge i risultati più interessanti per l’intensità della realizzazione e per l’emozione che riesce a trasferire. Molti sono gli esempi di quanto appena espresso, ma per il legame che ha con Il caso Arpur è, a parer mio, particolarmente interessante Autoritratto Arlecchino del 1981 che è stato scelto, infatti, per la copertina del libro stesso.
Il moltiplicarsi dei piani ben rappresenta la complessità del personaggio così come dell’autore e della sua pittura. La scacchiera composta di tanti tasselli, il prisma colorato di tante diverse sfaccettature è un’immagine perfetta per rappresentare il libro: tanti pezzi diversi, modificati che vanno a ricomporsi in una nuova identità sia esteriormente e tanto più interiormente. Analizzando l’opera dal punto di vista del soggetto e della resa formale, ciò che emerge in modo inequivocabile è la ricerca dell’artista, attraverso la scrittura e la pittura intimamente legate, di ricomporre e riaffermare la propria identità.
Scegliere di dipingere il proprio autoritratto, come è stato puntualmente analizzato da Alberto Boatto nel suo saggio Narciso infranto. L’autoritratto moderno da Goya a Warhol e da cui sono tratte le mie riflessioni, è una scelta specifica e complessa in quanto conoscenza e sovrapposizione di identità e alterità. La domanda che si pone l’artista che si accinge a dipingere un ritratto è differente rispetto a quella che si pone quando lavora al proprio autoritratto: nel primo caso è “Chi sei tu?”, nel secondo è “Chi sono io?”. “L’autoritratto non è affatto il ritratto, corrisponde semmai al suo rovescio”[1], il punto di vista è posto all’interno, è come vedere la parte concava o convessa di una forma per di più la prima riempita della propria anima. E’ assodato che sia il ritratto che l’autoritratto “si rivolgono alla fisionomia, all’apparenza dei corpi e dei volti”, ma in questo mutamento di pronome personale “Io” – “Tu” risiede la sostanziale differenza. E’ interessante, inoltre, riflettere come in realtà noi siamo invisibili a noi stessi nel volto, possiamo sì avvertire qualcosa di molto più segreto che è l’aurea che fascia il nostro viso e che è stato motivo di riflessione fin dai tempi di Socrate, ma non lo possiamo guardare, ed anche del nostro corpo possiamo vedere solo le estremità. Allora, paradossalmente, il volto degli altri resta sempre più famigliare del nostro, ma tale invisibilità a noi stessi ci consente, in realtà, di vivere in uno stato di inconsapevolezza rassicurante (anche quando utilizziamo lo specchio non ci è mai dato di vederci come gli altri ci vedono poiché vi è un mutamento nell’ordine simmetrico da destra a sinistra).
“Desiderare di portarsi dinnanzi a se stessi, di passare dalla parte antistante quel delicato specchio che dispiegano i propri occhi, è l’operazione non priva di insidie a cui si espone il pittore quando si accinge a eseguire il proprio autoritratto”[2]. Il divenire visibili a se stessi, l’atto di passare da dentro a fuori presuppone il misurarsi e il giudicare se stessi e ne consegue che ci riscopriamo altri da noi e l’identità subisce una frantumazione. L’estraneità a se stessi e alla propria immagine, nella contemporaneità e allo stesso modo in Carli, assume dimensioni sempre più invadenti.
“L’autoritratto conferma l’affermazione capitale di Rimbaud: “Je est un autre”, nella quale l’identità si è fatta alterità irrimediabile, distanza, separazione, divorzio”.[3]
La disgregazione è però anche allo stesso tempo “un’apertura, una finestra, un ponte, la testimonianza che si è oltrepassata una condizione di sordità e di chiusura”. Definire se stessi “significa porsi in una condizione di ascolto, di interrogare le forze estranee, accettando di lasciarsi penetrare e sconvolgere da esse”[4] e il volto diventa il luogo dove il travaglio di tali processi è visibile.
L’autoritratto, come ricorda ancora Boatto, si lega alla figura mitica di Narciso: confronto con l’altro da sé, con il doppio, la ricerca della propria identità, della conoscenza del proprio io. “Narciso si riflette e riflette alla ricerca della propria identità, come fa l’artista che attraverso la propria immagine, spesso vuole giungere al cuore dell’esistenza”[5].
Più specificatamente, dal punto di vista formale e del soggetto il riferimento sono certamente il cubismo e Picasso.
Il cubismo ha introdotto la resa simultanea degli oggetti visti da differenti punti di vista e la compresenza sulla superficie bidimensionale della tela di elementi vicini e lontani. Esso ha soprattutto introdotto, al di là delle codificate dimensioni dello spazio euclideo, la quarta dimensione: quella del tempo. Le immagini si compongono di schegge di realtà, viste da angolazioni diverse e in tempi diversi e ricomposte in una simultaneità del tutto originale; è rappresentato, inoltre, il tempo stesso con cui l’artista e il fruitore si appropriano dell’oggetto, ossia lo conoscono.
In Autoritratto Arlecchino, Carli sembra allora mostrarsi non solo da punti di vista diversi, ma anche in momenti differenti della propria esistenza.
Anche per quanto riguarda il soggetto del personaggio di Arlecchino non si può non pensare all’associazione con i giocolieri, i panciuti pagliacci, gli acrobati e gli altri artisti del circo, ritratti da Picasso nel suo periodo rosa.
Le origini di Arlecchino sono poi antiche e complesse (demone meridiano o forza positiva della natura, tramite fra il mono dei vivi e quello dei morti) e con accezioni anche, ma non puramente ambigue e negative (si pensi ad esempio alla maschera della Commedia dell’Arte). Credo tuttavia che qui sia appropriato evidenziarne l’aspetto simbolico di ricerca, di tentativo di cambiare se stessi e le situazioni, spesso immutabili, di antico tormento che ci riguardano oltre che di trovare una propria coerente identità. La frantumazione nella figura di Carli che estende al volto la divisione prodotta dalla losanga del costume di Arlecchino, con il suo essere un doppio triangolo e tutta la simbologia che ne consegue, accentua così ulteriormente il concetto di maschera, dell’apparire altro da quello che siamo, che non sempre nasconde fragilità. La maschera sfaccettata da allegri colori a volte cela indomita sopportazione di sofferenza, il pagliaccio stesso è l’emblema della convivenza di gioia e di dolore, di speranza e di nostalgia.
Per concludere vorrei allora citare un brevissimo passo tratto da Il caso Arpur che vi sarà chiaro solo quando leggerete il romanzo: “ad un aspetto da asceta, teso, affilato, trasparente, era stato sovrapposto quello ottuso e informe di un clown”[6].
[1] A. Boatto, Narciso infranto. L’autoritratto moderno da Goya a Warhol, Gius. Laterza & Figli, Roma-Bari 2005, p. 5
[2] Ibidem, p. 6
[3] Ibidem, p. 24
[4] Ibidem
[5] F. Ugoletti, Identità/alterità: l’artista di fronte lo specchio di Narciso, in S. Ferrari (a c.d.), Autoritratto, psicologia e dintorni, CLUEB Editrice, Bologna 2004, p. 9
[6] A. Carli, Il caso Arpur, Casa Editrice Tresogni, Ferrara 2014, p.47